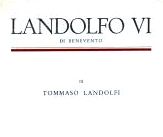Il “Landolfo”, Landolfi, i Landolfi.
di DANIELE VISENTINI
È probabilmente noto ai lettori di Tommaso Landolfi, e indubbiamente è assai noto ai suoi interpreti e critici, il giudizio espresso dall’autore in una rara intervista televisiva circa il suo Landolfo VI di Benevento. Incalzando egli stesso l’intervistatore a chiedergli quale fosse il libro prediletto tra i suoi, e perciò programmando questo speciale verdetto con qualche anticipo, Landolfi asserisce senza tentennamenti che «Il Landolfo […] è senz’altro il suo migliore libro e, per conseguenza, è il meno apprezzato»(1).
Poema drammatico d’impianto storico in endecasillabi sciolti – o tragedia, come la presentò lo scrittore stesso a Bigongiari, in un tono tra l’incredulo e il faceto (2)– il Landolfo VI è opera tra le più anomale, enigmatiche del corpus landolfiano. A soffermarsi di recente sull’intervista citata, allo scopo di comprendere quali fossero le ragioni sottese alla predilezione di Landolfi per un’opera tanto inusitata, è stato Paolo Zublena. Una volta appurata la natura letteraria, artificiale della lingua del Landolfo, a tal punto ricca di riferimenti alla tradizione, a tal punto antimimetica da potersi definire «il pastiche di un pastiche virtuale»(3), Zublena definisce il poema tragico di Landolfi «un monumento alla chiusura nella confortevole e confortante prigione della letterarietà (prigione del genere, prigione del metro, prigione della lingua)»(4). In questa prospettiva il Landolfo VI di Benevento è inteso come tripudio cosciente della maniera, un ultimo sforzo volto a incarcerare – ma al fine del suo mantenimento – un rimasuglio di purezza originaria che la realtà, insensibilmente e con costanza, minaccia.
La tipologia d’approccio linguistico-stilistica sperimentata con successo da Zublena, come i più frequenti interventi critici di natura tematica(5), non esauriscono tuttavia le possibilità di tentare una conciliazione tra simili riscontri interni e alcuni elementi esterni, che nell’analisi coinvolgano l’esperienza umana di Landolfi durante gli anni di stesura del poema. Quando lo scrittore si riferisce al Landolfo come alla sua opera capitale, infatti, è quanto meno improbabile non supporre un’allusione alla natura autobiografica dell’opera, e sia d’un autobiografismo trasversale, operato mediante un transfert cronologico e ideologico così estremo da lambire la fattispecie della visione onirica. Eppure, con la paradossale schiettezza oscura che Debenedetti individuò quale cifra endemica alla scrittura del Nostro(6), la sovrapposizione tra Landolfi e Landolfo – si noterà senza sforzo – è esplicitata già dalla loro omonimia quasi completa.
D’altronde, questa proiezione è dichiarata con aperte parole nella prima pagina di un racconto che, come aveva intuito Bigongiari(7), si riallaccia proprio alle fasi di stesura del Landolfo. Pubblicata dapprima nel 1956 su «Tempo Presente», e poi inserita nelle raccolte Mezzacoda e In società, la breve narrazione dei Due figli di Stefano, alla maniera d’un sistema di specchi, costruisce in effetti un’allegoria sull’allegoria, garantendo così la possibilità di percorrere a ritroso le fasi del dialogo landolfiano tra vita e arte e, infine, restituendo all’originaria materia del Landolfo VI le sue dimensioni esatte.
Nel racconto si assiste alla libera ripresa di un topos della tragedia classica, quello della lotta fratricida; i figli del protagonista, la cui duplice vocazione di scrittore e di novello sposo è apostrofata, già all’avvio della narrazione, come fallimentare, altri non sono se non un libro e un nascituro in carne e ossa, ovvero la letteratura e la vita(8). Andrea, l’anèr, è figlio in senso proprio dell’autore; per dire meglio egli, siccome frutto di un matrimonio d’occasione, è continuatore legittimo dei malesseri paterni, di un’ansia spregiudicata di vita nelle sue varianti più egoistiche. Squarciando il ventre della madre, Andrea si palesa infine nella propria mostruosità: egli, più simile a un insetto o a un demonio che a un uomo, non ha dita, ha pelle squamata, a strisce, e sul suo capo emergono protuberanze ossee simili a corna; al posto del sesso, infine, è dotato di «una specie di immenso bellico o piuttosto di orecchio, cigliato»(9). Come un suo celebre predecessore, quel «pesce col becco» o «uccello spiumato»(10) che era il feto abortito da Chiara nei Viceré, Andrea simboleggia un’esistenza dedicata al solo ampliamento del proprio Io sotto le mentite spoglie della schiatta. La creatura è emblema di una volontà tutta umana di sussistenza, in cui generazione e degenerazione coesistono.
L’altra parte della tragedia è giocata da Patrizio, fratello e agone del carnale Andrea, il quale è invece un essere celeste: patrikòs per antonomasia, esso non è per intero figlio dell’autore, ma all’opposto lo precede, preesiste nella sua nobiltà, quasi ingenerato e ingenerabile, agli stessi sforzi creativi di Stefano. Nel complesso, Patrizio rappresenta la letteratura; a livello più specifico, però, non vi è dubbio che egli rappresenti il Landolfo VI medesimo, il libro migliore di Tommaso Landolfi. Qualora a dimostrare ciò non bastasse il nome-parlante del personaggio, sarebbe infatti sufficiente leggere la laconica descrizione di Patrizio per svelarvi immediatamente i caratteri di Landolfo. Il figlio prediletto da Stefano, «stato uomo di guerra e di mondo», è «un […] remoto e pressoché mitico antenato» di Stefano stesso(11), come della prosapia semi-mitica landolfiana è remoto antenato l’ultimo principe longobardo di Benevento prima della conquista operata dal Guiscardo, l’atenulfingio Landolfo.
A questo punto la voce narrante dei Due figli di Stefano aggiunge un altro dettaglio, essenziale a chiarire non il rapporto d’identità tra Patrizio e Landolfo, bensì quello primigenio tra l’autore e il suo figlio-antenato longobardo. Malgrado Stefano (e si legga, in filigrana, Tommaso) fosse in realtà un successore di Patrizio, egli
lo chiamava da tempo suo figlio, intendendo che se fosse giunto a risuscitarlo ovvero a procrearlo non avrebbe soltanto reso lampanti a se medesimo le ragioni profonde della propria personalità, ma finalmente fornito l’esatta misura delle proprie possibilità di scrittore; poiché nel suo essere e nei suoi atti obliterati quegli pareva davvero riassumere la visione del suo discendente, o almeno pareva atto a ricevere tutti i sentimenti che a costui fosse piaciuto attribuirgli(12).
Patrizio-Landolfo è ciò che un figlio in carne e ossa non potrà essere mai, l’erede perfetto che si mira a costruire come si desidera, affinché sintetizzi ciò che nel padre appare solo sbozzato.
Proprio a motivo di questa tensione all’assolutezza, però, anche Patrizio come Andrea è destinato a nascere sotto le insegne della mostruosità e del fallimento. Mentre la giovane moglie dello scrittore è preda di doglie acute, sul sottofondo di urla Stefano concepisce la scena madre del suo dramma, la quale nell’immediato gli si mostra tra le cose più ispirate che la sua penna abbia prodotto. La notte appresso, appena si accinge a riprendere i fogli in mano («o in braccio», come con ironia appunta il narratore), ecco invece che il povero padre scopre di aver perso non uno, bensì due figli in un tempo:
Mio Dio, dove era il vigore che egli aveva creduto infondere nella sua opera, cosa erano divenute le parole fatali di Patrizio? Discorsetti vuoti di senso nuovo e profondo, cui solo una certa padronanza del mestiere attribuiva un’esteriore coesione. […] Dallo smorto testo che Stefano aveva sott’occhio il nominato Patrizio, riconvertito in labile larva, parlava ora un linguaggio trito e ozioso o, peggio, il freddo idioma della ragione(13).
Ugualmente al racconto La spada, dove lo sventurato protagonista, illusosi di risollevare la propria fortuna grazie a una splendente arma avita, scopre che essa piuttosto è la matrice della propria sventura e si ritrova all’improvviso tra le mani, al suo posto, una cosa «smorta come cenere, cupa come un tizzo spento»(14), qui Stefano si descrive «come chi, immaginando brandire una spada forbita, si ritrovi in pugno un salcio»(15). Un’epifania negativa, dunque, a dissipare le fantasie di grandezza di un padre tormentato.
Proprio il significato profondo della generazione, la paternità, la filiazione sono perciò i motivi che campeggiano al centro del Landolfo VI di Benevento – motivi tra i più complessi, involuti dell’intera produzione landolfiana. Come cronaca allegorica della stesura del Landolfo, il racconto sui Due figli di Stefano rende evidente e problematizza il rapporto dell’autore con la sua creatura, con la sua tragedia.
Che cosa si debba intendere per paternità, nell’universo delle significazioni landolfiane, lo si scopre però sfogliando le pagine di un altro scritto che, oltre ai Due figli di Stefano, è compendio necessario, anzi vero e proprio radiogramma del Landolfo. In Rien va, al contrario che nel racconto analizzato, l’autocoscienza dello scrittore ha difatti l’opportunità di mostrarsi al di là di ogni schema allegorico. Pur conscio del paradosso implicito in tale desiderio, già nelle prime pagine di Rien va Landolfi rimarca la propria volontà d’emancipazione dagli schemi letterari tout court, la sua voglia di godere da lontano, e con disincanto, il miraggio di una scrittura compiutamente spontanea:
L’infelice principio di questo diario mi scoraggia. Nel frattempo, esso già tenderebbe (nella mia testa e nei miei fiacchi pensamenti) a prendere una direzione, a ordinarsi, a comporsi, a scegliere gli argomenti. Cercherò d’impedirglielo: l’eterogeneo, l’eteroclito deve invece dominarvi – eppure anche questo è una specie di piano!(16)
Il risultato pragmatico di questo progetto è la compilazione di un diario, steso dal giugno del 1958 al maggio di due anni dopo, che accompagna quasi giorno per giorno lo scrittore nelle fasi cruciali del proprio presente artistico e, in un sol tempo, nelle minute contingenze della propria vita di uomo.
Com’è nota la predilezione di Landolfi per il proprio poema longobardo, altrettanto noto è lo strettissimo legame che intercorre tra Rien va e il Landolfo VI. Nelle pagine del diario, l’autore segue infatti da vicino gli sviluppi dell’opera, annota con minuzia i momenti cruciali della gestazione e i suoi dubbi a riguardo, spingendosi fino a numerosi tentativi d’auto-analisi letteraria. Se nella cornice simbolica e ironica dei Due figli di Stefano lo scrittore protagonista si riferiva al suo diletto Patrizio come a un figlio, è interessante notare che Tommaso Landolfi fa la stessa cosa in Rien va, questa volta senza alcun infingimento, nei confronti del suo poema. Per esso nutre un’apprensione a tratti drammatica, sollecitata da appassionate aspettative: «Povero mio Landolfo VI», lamenta paternamente l’autore; «Vedrà mai la luce, e sia tra l’indifferenza? Vi sarà almeno un riflesso di ciò che ho voluto dire?»(17). Il “genitore” di Patrizio, nei Due figli di Stefano, e di Landolfo, in Rien va, si muove guidato dall’anelito a una paternità perfetta – il che vuol dire scelta, gestita con coscienza da un padre ribelle alla meccanicità del dato biologico. Questo padre si riflette nei propri figli, sperando redenzione si sdoppia attraverso la loro immagine; di più, egli si purifica. Ecco allora che Landolfi, una volta constatate le difficoltà compositive che il Landolfo comporta, soggiunge: «Qualcuno mi dia atto della mia purezza. – Povero Landolfo, di nuovo; ché è pur vero che ci ho messo qualcosa di mio»(18).
Ma dove va rintracciato il significato della «purezza» implicata in tale rispecchiamento? E chi o che cosa, per contrasto, va ritenuto opposto alla catarsi, dunque spurio e irrelato? Sfogliando a ritroso le pagine di Rien va si ritrova un passaggio che giustifica l’accostamento tra il concetto di idea, del quale tanto Patrizio quanto Landolfo sono figli, e la purezza di spirito. «Idee davvero», spiega Tommaso Landolfi,
son quelle non passibili di attuazione purchessia […] né al postutto di espressione o formulazione, e […] unicamente in quest’ambito dovrebbe ridursi uno spirito puro (senza macchia, non puro spirito). Il fatto, ribadisco e rincaro qui, è degenerazione del farsi e non è della sua medesima natura. […] Ma di più: ogni idea realizzata non può essere che sbagliata e funesta(19).
Per uno scrittore come Landolfi, narcisista e assediato da ossessive «pretese metafisiche, cicliche, analogiche, traspositive»(20), l’idea fondamentale, la più sconvolgente, non può che essere quella della generazione. Nel caso di Patrizio-Landolfo, il concepimento è inteso in accezione ideale, fintantoché esso non giunge a realizzarsi – un paradosso, quest’ultimo, che alla luce di quanto detto circa l’inconciliabilità assoluta di idee e realtà risulta palese. Patrizio allora da figlio prediletto muta in aborto mostruoso; del pari il Landolfo, relegato in fondo a un cassetto, appare «come un serpente ivi arrotolato»(21). La purezza riacquisita da Landolfi per opera del suo principe longobardo, quindi, è destinata a serbarsi inespressa.
L’insanabile contrasto tra mondo delle idee e mondo reale cui fa cenno Landolfi, però, appare di doppia natura: se si riferisce in ultima istanza alle aporie della scrittura (la quale è sempre e comunque nutrita dall’illusione di sostituire, o addirittura di migliorare la realtà, vanificando l’originaria purezza che le deriva dall’essere schietta astrazione), nondimeno tale contrasto è estrapolabile anzitutto dal parallelismo tra esistenza reale e ideale. La prima è la vita, in una volta regolata e incosciente, del fare; è cioè la vita attiva in tutte le sue manifestazioni isolanti o aggregative; di necessità, il termine opposto è rappresentato dall’approccio contemplativo all’esistenza, approccio anarchico e mai consequenziale di cui l’idea come eterna crisalide si ammanta. In due soli termini, si può perciò parlare della dicotomia inveterata tra negotium e otium, dove il secondo termine, prediletto da Landolfi, è materia seminale della letteratura stessa e di ogni altra idea.
In quanto inattiva, l’accidia fa tutt’uno con la purezza dell’idea. Sicché come la purezza essa si mostra inattuabile: nella realtà non si possono portare a compimento le idee, e allo stesso modo nella vita, che presuppone per forza l’azione, non si può essere accidiosi fino in fondo. E tuttavia l’illusione di fare dell’ozio stesso una realtà presente e positiva, di realizzare l’idea, è tentazione costante per ogni scrittore. «Daemonium nobis haec otia fecit», recita quindi l’epigrafe di Rien va, invertendo il segno positivo dell’originario passo virgiliano(22); lo fa allo scopo di avvertire che il daemonum cibus(23) per eccellenza – l’invenzione poetica, e per estensione l’idea – sarà sempre e comunque ostacolo alla vita, spina nel fianco dell’uomo, sovrarealtà irrealizzabile. Parto abominoso per conseguenza è la letteratura, ché fallisce sempre il riscatto dei propri padri da una realtà imperfetta.
Tornando alla tematica della paternità, però, rimane da sciogliere un ultimo nodo semantico, il quale restituisce al Landolfo le proporzioni che esso dovette assumere agli occhi del suo autore. Tenuto conto che nei Due figli di Stefano era proprio il dualismo di realtà e idealità, di azione e accidia a conferire valore tragico al racconto, e tenuto conto ancora della chiara identificazione tra Patrizio e Landolfo, bisogna capire qual è il contraltare “reale” al poema longobardo di Tommaso Landolfi. Bisogna capire chi è Andrea.
Due settimane prima d’intraprendere la stesura di Rien va, nella vita di Tommaso Landolfi accadeva un evento determinante, che da allora in poi avrebbe scatenato un’inattesa incursione della realtà nell’ozio del letterato picano: il 19 maggio del 1958 veniva alla luce a Roma la sua primogenita Idolina. Il diario stesso, a ben vedere, nasce come resoconto e antidoto a questa circostanza cruciale; quasi che Landolfi, violata la sua abituale solitudine dall’imporsi di responsabilità verso l’esterno prima sconosciute, esiga ora un luogo del tutto suo, un limbo dove il puro pensiero individuale (l’idea) possa riacquisire vigore. Rien va, in sostanza, tiene a battesimo due creature corrispettive di Andrea e Patrizio, le maupassantiane «deux âmes»(24) della sua coscienza: il prodotto del sangue, Idolina, e il prodotto dello spirito, il Landolfo VI di Benevento. Riconoscendo ambo questi figli come suoi, Landolfi ne sperimenta simultaneamente il dialogo – e quello che d’acchito parrebbe un soliloquio si trasforma, così, in intima riflessione sull’altro.
È quindi certo che il testo del Landolfo VI di Benevento sia costruito attorno a questi fondamentali argomenti: il conflitto tra idea e realtà, quello parallelo tra letteratura e mondo e, a fare da cornice all’insieme, il sentimento della paternità.
Già un primo sguardo alla rappresentazione del personaggio, infatti, dissipa molti dubbi. Il principe longobardo Landolfo è un padre che toglie alla propria discendenza qualsiasi possibilità di resistere al tempo; egli, dinnanzi all’avanzata di Roberto il Guiscardo, nega un futuro di gloria al figlio Pandolfo, resistente guerriero, e lo sprona piuttosto ad abbandonare le proprie velleità difensive. A vessillo delle proprie argomentazioni, come il Landolfi di Rien Va, Landolfo pone la ragione dell’inconciliabilità tra il mondo delle idee e la realtà; e lo fa mentre dialoga con il figlio, per suggerirgli di vivere senza auspicare alcun obiettivo ideale:
Che funesta sete vi sospinge
A consumare in atti il vostro sogno?
Se si fa carne morirà, corrotto
Vi giacerà ben presto ai piedi! Oh figlio!
Non intendi tu dunque che a serbarlo
Eternamente vivo, il vostro sogno,
Devi lasciarlo nel mio limbo?(25)
Il limbo di Landolfo è l’accidia, la contemplazione oziosa che preserva la purezza delle idee dalle contaminazioni con gli atti:
E di’, vi è forse cosa
Che meriti esser presa con istudio
E con furore, quasi gareggiando?
Che vale il conquistato con sudore?
Quello che chiede lotta non è degno
Del nostro desiderio, se ci abbassa
Primamente, ci imbratta, ci fa servi
Di sordidi rovelli e abbiette brame.
Il degno non è quello che ci viene
Di propria voglia, leggermente, come
Arridendoci e che ci lascia puri?(26)
Una simile prospettiva di passività all’incursione del reale segna il ripiegamento verso una dimensione priva di tempo, che è sintomatica del più livido horror vacui(27). Quella innalzata da Landolfo, ormai convinto della morte del figlio per sete di gloria – di quel figlio che lo aveva accusato, con dure parole, di ignavia e mollezza: «Ah padre, ancora / Guardi al passato. Non è d’altre volte / Che la sorte degli uomini si trama»(28) –, è allora una querela contro la vanagloria che sospinge gli esseri umani tutti, dai guerrieri agli amanti, dai potenti ai poeti, a inseguire il fuoco fatuo di un avvenire impossibile:
Venga chi mi mostri
Non esser vana cosa la potenza,
La sapienza, la gloria, le dovizie,
L’amore e gli altri beni umani, cosa
Vana lo stesso volgere del mondo,
Non isvanire i canti dei poeti
Come fumo nell’aria senza traccia,
E le preci levate al Creatore!(29)
Come il Landolfi della BIERE DU PECHEUR, Landolfo urla la propria disillusione, la perdita di fede nel tempo, nello spazio e nella natura umana: «Galassia oscura miserevole prigione patria, / Non v’è gloria per i tuoi figli»(30), pare di sentirlo dire.
A causa di una disperazione tanto livida, la volontà finale dell’ultimo principe longobardo di Benevento – se di volontà si tratta – è la sepoltura, la negazione della realtà circostante. Come ogni sguardo privato di avvenire, anche il suo è uno sguardo che sa sia di morte, sia di rimpianto. E somiglia di nuovo a quello del suo autore, che in una delle pagine più intense del suo diario sintetizza così il proprio disincanto verso qualsivoglia orizzonte presente e futuro:
La mia ansia di risalire il tempo, di tornare, se non al nulla primordiale, alla assorta vita prenatale, il mio orrore razionale e sentimentale del presente e forse del futuro, la mia inettitudine all’esistenza consociate e all’esistenza senza più, erano già allora riusciti a questa specie di formulazione imperativa […]: Rientrare nell’utero materno(31).
In una tale prospettiva esistenziale, che per gli oziosi Landolfo e Landolfi può essere accettata solo per mezzo di un consapevole ritiro, o comunque tramite un avvilimento pervicace del proprio agire, ci si potrà mai augurare che i figli protraggano il destino dei loro padri? Forse è proprio nella risposta a questo interrogativo che si nasconde la chiave interpretativa dell’opera.
Come si è detto, Landolfo VI nega a suo figlio Pandolfo, e pertanto all’intera stirpe dei landolfidi una sopravvivenza che non sia meccanica, priva di ideali e di gloria; questo poiché l’idea, unica fonte della vera vita, è demoniaca in essenza e concede all’uomo inservibili attese e dolori, al di là dei quali non vi è conquista che valga la pena d’essere bramata. Malgrado ciò, però, sembra che dietro al suo personaggio la voce viva di Landolfi esorcizzi la propria esistenza accidiosa, consacrata a «Parole infeconde, torve e fosche»(32), per predisporsi all’inevitabile incursione della realtà annunciata dalla paternità del sangue. La domanda, a questo punto, si impone da sé: potrebbe mai essere il Landolfo VI una concessione estrema (estremistica) alla letteratura che celi, dietro la sua facies mortuaria, proprio l’urgenza di liquidare la letteratura stessa?
Non si può negare che, sotto tanti punti di vista, il poema segni uno spartiacque nella produzione di Tommaso Landolfi. Collocabile alla metà della sua carriera, esso inaugura una nuova stagione di vita e di scrittura, l’appartata stagione sanremese durante la quale Landolfi si mostra meno incline alle strutture allegoriche o ai rutilanti giochi formali saggiati sino agli anni Cinquanta. È questa anche la stagione della rinuncia alla “favola”, all’inventività diegetica di cui Landolfi, proprio in Rien va, si era dichiarato carente per indole(33). Alla ispirazione narrativa, che si nutre di forme sempre più brevi, ironiche, d’occasione, prediligendo l’espediente icastico dell’elzeviro, si affianca allora l’ispirazione lirica. Le due opere fondamentali di questo secondo Landolfi, Viola di morte e Il tradimento, sono raccolte poetiche strettamente connesse l’una con l’altra, il tono generale delle quali si mantiene d’una intimità e un’astrattezza notevoli. Viola di morte – «ultima Tule» nella geografia letteraria landolfiana, come la si ebbe a definire(34) – è un fiore nel deserto del pensiero, o un ultimo accordo che si alza dal silenzio, e che a omaggiare il silenzio è comunque consacrato. Il suo «grave e terribile seguito»(35), Il tradimento, è perciò il documento di una rinuncia ormai avvenuta – al morto pensiero, alla letteratura traditrice, alla parola definitiva dell’assiuolo che mai uomo saprà riprodurre(36). Nella coazione a ripetere dell’esistenza, però, dove qualcosa va distrutto qualcos’altro di necessità emerge a sua sostituzione. Ed ecco che, ancora a anni di distanza dalla sua nascita, è sempre Idolina la pura vestale di una realtà incontrollabile, sull’altare della quale sacrificare la lacera scorza dell’idea. Il padre sconfitto dedica alla figlia una gran parte dei componimenti inseriti nella raccolta. E se Landolfo rivolto a Pandolfo lanciava il suo struggente invito a vivere per vivere, anche Tommaso invita Idolina a desistere dai sogni paterni di purezza:
Idolina, ti conceda la sorte
Di tralignare sempre,
Di non perdere le tempre
A corteggiare la morte,
A vagheggiare le forme
Compite, cui fosse affidato
L’estremo compenso, il riscatto
Da tutte le infamie. Lo vedi:
Sono sorelle perfezione e morte
(O son la stessa cosa forse)
Ed ambedue deludono. E tu, vivi
Lungo aleatorie, provvisorie orme,
Libera, casuale ed imperfetta,
Sposa a tutti i cammini e a tutti i trivii…
Fa’, dico, tutto quanto è in tuo potere
Per non trovarti un dì tradita,
Anzi negletta dalla morte, quale
Il tuo misero padre(37).
A dispetto di ciò, un avanzo di speranza rimane. Segretamente Landolfi si bea dell’illusione che la figlia non carpisca il suo consiglio, e al contrario si disponga a svellere la tanto agognata purezza della parola, riscattando suo padre dal tradimento:
[…] Ella infine,
Oh Dio, conoscerà le poche
Parole pure che avrò scritte, e in esse
Conoscerà se stessa?
Ebbene,
Quel giorno forse, o mio deluso amore,
Avrai riscatto tu e vendetta(38).
Di nuovo Landolfi pare dirci – pare dirlo ai lettori, a sé, alla sua Idolina – che realtà e irrealtà sono fatte per predarsi a vicenda, che si rincorreranno sempre senza sopraffazioni. La vita integralmente reale augurata alla figlia è traditrice quanto quella integralmente irreale tentata dal padre attraverso l’esercizio dell’ozio. Vano allora tentare qualunque forma di purezza, da una parte o dall’altra, quando è solo dall’interazione di realtà e irrealtà che si costruisce la vita umana.
Tornando a leggere il diario, del resto, ci si accorge che i due figli di Landolfi, Landolfo e Idolina, ricreano tale interazione in più di un senso, quasi come fossero i meccanismi incontrollabili di un doppio movimento(39). Il «povero» poema, in principio consustanziale all’autore, a poco a poco gli si allontana, diventa parvenza insinuante e pericolosa come di un serpe; e la realtà d’Idolina, dapprincipio tanto estranea, gli si avvicina inesorabile. In effetti, se verso il Landolfo VI lo scrittore muta l’accorata immedesimazione iniziale in un completo ripudio, fallendo perciò i propri obiettivi, l’esatto contrario avviene nei confronti della figlia. Rimanendo identica la conclusione fallimentare, il rapporto di Landolfi con la piccola si evolve da un rifiuto a una accettazione drammatica:
Notizie dell’amor paterno. Dovrei odiarla per la sua infinita importunità, e in particolare e soprattutto per la spaventosa rappresentazione di me stesso e della mia vita che in ogni momento mi offre, per quel suo ozio senza speranza che i barbassori gabellano per conquista del mondo; perché dunque non la odio?(40)
Questo sentimento cresce fino a divenire una proiezione ideale del Sé nell’altro, un illusorio travaso del proprio ozio e della propria vena contemplativa nel simulacro futuribile della figlia:
Cosa vorrei infine che diventasse? – Come difendersi dal desiderio che ne venga qualche grande scrittrice o attrice o… ma non pare sappiano fare altro? Eppure come difendersi, anche, dal senso, dalla certezza che tutto quanto facesse o farà sarebbe o sarà invano? Tra cent’anni, tra un volger di ciglia, sarà certamente morta e sepolta. – Certamente? Ecco, di questo forse sarei felice: che realizzasse la grande idea del suo sciagurato padre, che vincesse la morte(41).
La formula apotropaica, allora, è quella che prova a sostituire la parola letteraria con una presenza tangibile ed eletta: «Parole e infestazioni dell’intelligenza, fatevi indietro davanti alla Idolina!»(42).
Demandate le cure e i rovelli ideologici al suo alter ego letterario, e confinato quest’ultimo nel maniero crollante del proprio ozio, è come se Landolfi riuscisse a trasfondere un senso nei tessuti della realtà. Un senso, si ribadisce, sempre tragico, che non risolve i dilemmi fondamentali dell’esistenza; anzi, semmai li esacerba con la rinuncia al più grande tra i miraggi: ora è decretato che, se non la realtà, di certo le idee non possono auto-sussistere.
Il Landolfo VI di Benevento, in una formula, è il manifesto più estremo della divaricazione tra realtà e letteratura che Landolfi abbia concepito. Qualsiasi elemento vitalistico, qualsiasi appiglio alla mimesi, formalmente e a livello contenutistico, è in esso strozzato sul nascere; la stessa lingua, antimimetica per vocazione, è quella castrante dell’autoreferenzialità letteraria. Il panorama è già quello introspettivo e uggioso del Tradimento, dove ogni atto è interdetto sul nascere da un senso di vertigine costante. Landolfo, per suggellare la disfatta delle sue impure, ereditabili illusioni, deve condannare tutti i Landolfi della storia all’oblio, tutti gli accidiosi infatuati dell’idea, precipitando nella tenebra la concatenazione del prima col dopo. Malgrado ciò il poema capolavoro di Landolfi, giacché rovescia la piega della realtà, arriva a svelare più di ogni altra sua opera gli ingranaggi segreti dell’anima dell’autore. La stessa condanna dell’otium, nel Landolfo VI, vale allora come atto di contrizione, come rinuncia al sogno e, infine, come richiesta di riammissione alla vita, a seguito del tremendo tradimento della letteratura. È la «sterilizzazione, o uccisione preventiva»(43) tante volte vagheggiata da Landolfi – o meglio è abiura, là dove le leggi razionali della realtà censurano per forza le idee, e inutile è resistervi.
NOTE:
(1) La citazione è ripresa, con una minima modifica approvata da un riscontro sul video originale dell’intervista, da PAOLO ZUBLENA, La maschera tragica del manierista: parossismo stilistico del “Landolfo VI di Benevento”, in Il teatro di Tommaso Landolfi, a cura di ANNA DOLFI e MARIA CARLA PAPINI, Roma, Bulzoni, 2010, pp. 77-87, a p. 77.
(2) Cfr. Sette lettere a proposito di due “pippionate”, «Paradigma», n. 3, 1980, pp. 449-53, a p. 449.
(3) La maschera tragica del manierista, cit., p. 82.
(4) Ivi, p. 84.
(5) Lo stesso Zublena ricorda come quasi tutte le letture del Landolfo, sino a quel momento, abbiano ruotato attorno a cardini tematici fissi. Primo fra tutti, il tema dell’accidia, su cui si basano ancora gli studi di ISABELLA CARACCIOLO, Landolfi longobardo. Il “Landolfo VI di Benevento”, «Paragone», nn. 72-74, 2007, pp. 35-47, ma anche quello più recente di ANDREA CORTELLESSA, Malattie della volontà. Landolfo e il manuale dell’accidioso, in Il teatro di Tommaso Landolfi, cit., pp. 59-75.
(6) Secondo Debenedetti, il modo letterario trascelto da Landolfi è quello che coinvolge «tutta la chiarezza al servizio del massimo di procurata oscurità, o meglio occultamento» (GIACOMO DEBENEDETTI, Il “Rouge et le Noir” di Landolfi, in Intermezzo, Milano, Mondadori, 1963, pp. 213-18, a p. 215).
(7) Tre anni prima di essere stampato interamente, il Landolfo VI di Benevento viene anticipato sulla rivista «Paragone», che ne pubblica l’Atto IV. Alla fine dell’estratto, in una nota corsiva viene proposto un brano centrale da I due figli di Stefano, cui fa seguito questo commento, in forma anonima: «C’è forse, vien fatto di domandarci, un po’ di quel Patrizio, si licet, in questo incompiuto Landolfo?» (LANDOLFI, Landolfo VI di Benevento, «Paragone», n. 82, 1956, pp. 36-46, a p. 46). La risposta di Tommaso Landolfi a un simile tentativo d’interpretazione arriva subito per lettera al Bigongiari (che, appunto, è il vero autore del breve commento: cfr. le Note al Landolfo IV, in Opere I (1937-1959), a cura di IDOLINA LANDOLFI, Milano, Rizzoli, 1991, p. 1038). L’autore del Landolfo, non a caso, afferma di aver trovato la nota «indiscretissima», confermando così, implicitamente, l’esattezza del rimando (Sette lettere a proposito di due “pippionate”, cit., p. 452).
(8) Proprio l’incipit del racconto non lascia dubbi in proposito; in esso, che introduce i Due figli di Stefano quasi al modo di una rubrica, o di un sunto dell’allegoria intera, si legge già a chiare lettere l’esito finale della vicenda: «A suggellare il suo fallimento nella letteratura e nella vita, Stefano si sposò. Il che ad ogni modo vuol dire che tra le due, qualunque fosse in realtà la più importante, aveva vinto la seconda» (LANDOLFI, I due figli di Stefano, in La spada, in Opere II (1960-1971), a cura di IDOLINA LANDOLFI, Milano, Rizzoli, 1992, pp. 134-39, a p. 134).
(9) Ivi, p. 138.
(10) FEDERICO DE ROBERTO, I Vicerè, Torino, Einaudi, 1990, p. 283.
(11) I due figli di Stefano, cit., p. 134.
(12) Ibid.
(13) Ivi, p. 139.
(14) ID., La spada, in La spada, in Opere I, cit., pp. 283-88, a p. 288.
(15) I due figli di Stefano, cit., p. 139.
(16) ID., Rien va, Firenze, Vallecchi, 1963, p. 13.
(17) Ivi, p. 68.
(18) Ivi, p. 72.
(19) Ivi, p. 63.
(20) Ivi, p. 14.
(21) Ivi, p. 113.
(22) «O Meliboee, deus nobis haec otia fecit» (Bucoliche I 6).
(23) Si rimanda a un passo dell’epistola XXI di San Girolamo: «Daemonum cibus est carmina poetarum, saecularis sapientia, rhetoricorum pompa verborum. Haec sua omnes suavitate delectant: et dum aures versibus dulci modulatione currentibus capiunt, animam quoque penetrant, et pectoris interna devinciunt» (HYERONIMUS, epist. XXI 13, 4).
(24) Si rimanda qui, molto sinteticamente, alla coscienza del doppio presente in scrittori quali Poe e, appunto, Maupassant, il quale (e perciò vale il parallelismo con Landolfi) sviluppa l’ossessione per un altro non più particolare, ma tanto generalizzato da coincidere con ogni sinapsi del sé e, per conseguenza, da implicare il suo sdoppiamento (cfr. GUY DE MAUPASSANT, Sur l’eau, in Au Soleil, texte établi par GILBERT SIGAUX, Lausanne, Editions Rencontre, 1962, pp. 310-11).
(25) LANDOLFI, Landolfo VI di Benevento, in Opere I, cit., pp. 889-967, a p. 927.
(26) Ivi, p. 928.
(27) Horror vacui che, naturalmente, trova nette rispondenze anche in altri testi contemporanei al Landolfo VI di Benevento, e che si rivela quindi appannaggio di Landolfi stesso. Si veda per esempio l’elzeviro intitolato Ombra di forca, appuntato dallo scrittore sul retro del quaderno di Rien va, il quale culmina in un “dialogo” serrato del personaggio – e dell’autore – con la propria coscienza: dove a delegittimare la quête di obiettivi momentanei che giustifichino l’innata ambizione dell’uomo a «una vita armonica, feconda, serena», che giustifichino l’ambizione altrettanto innata all’altro, implicita nell’idea del matrimonio, e che giustifichino finanche la volontà di protrazione sub specie eternitatis del proprio io, attraverso la procreazione, si para un muro di insormontabili «E poi?». (LANDOLFI, Ombra di forca, in Un paniere di chiocciole, in Opere II, cit., pp. 826-29, a p. 829).
(28) Ivi, p. 923.
(29) Ivi, p. 945.
(30) TOMMASO LANDOLFI, dalla Terza poesia in epigrafe a LA BIERE DU PECHEUR, in Opere I, cit., p. 569.
(31) Rien va, cit., pp. 30-31.
(32) Landolfo VI di Benevento, cit., p. 964.
(33) Rien va, cit., p. 19.
(34) La definizione, ricordata da Landolfi nella Nota iniziale del Tradimento, è di Citati (cfr. LANDOLFI, Il tradimento, Milano, Rizzoli, 1977, p. 5).
(35) Ibid.
(36) Il riferimento va al racconto che chiude il Dialogo dei massimi sistemi, «Night Must Fall», in cui Landolfi fa riferimento alla capacità dell’assiuolo di modulare un unico monotono verso il quale, al contrario delle molteplici approssimative parole scandite dall’uomo, possiede un’apparenza definitiva (cfr. LANDOLFI, «Night Must Fall», in Dialogo dei massimi sistemi, in Opere I, cit., pp. 102-15, alle pp. 103-04).
(37) Il tradimento, cit., p. 72.
(38) Ivi, p. 48.
(39) Non è forse a caso che Tommaso Landolfi scelse la modalità d’approccio diaristica anche in occasione della nascita del suo secondogenito, Landolfo – nome di battesimo significativo e, senz’altro, ironicamente allusivo al poema. Proprio come in Rien va, effettivamente, anche in Des Mois, terzo e ultimo diario di Landolfi, i rimandi alla rinnovata paternità sono intervallati da rinvii ai parti letterari, in specie alla composizione degli elzeviri e del racconto Sguardi.
(40) Ivi, p. 201.
(41) Ivi, pp. 196-97.
(42) ID., Rien va, cit., p. 97.
(43) ID., Cagna celeste, in Un paniere di chiocciole, in Opere II, cit., pp. 817-20, a p. 819.