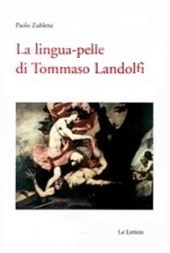Dall’Introduzione a La lingua-pelle di Tommaso Landolfi
La lingua, sfinge che incanta l’intera opera narrativa landolfiana, palese chimera inseguita durante la stesura dei diari, è soggetto fondamentale alla decifrazione del “personaggio” e dell’uomo Landolfi. Non solo e non tanto la lingua in falsetto, artata, manierata, e come tale studiata nel cavo di ogni sua piega allo scopo di realizzare una prosa unica per accuratezza e complessità del vocabolario, bensì una lingua più concretamente falsa; una lingua (come lo stesso Landolfi ebbe a definirla nella BIERE) «falsamente classicheggiante, falsamente nervosa, falsamente sostenuta, falsamente abbandonata»: falsa in tutti i sensi, dunque falsa per vocazione. Dove all’aggettivo in questione non si fornisse un mero significato negativo – che d’altronde testimonia lo sfumare del dilemma in tragedia, posto che alla scrittura, come alla vita, una armonizzazione tra forma e contenuto non possa imporsi –, si scoprirebbe però, all’origine della falsità, la finzione. E, infine, se il risvolto esterno della poiesis, della creazione, coincide necessariamente con la finzione, va da sé che la falsità della scrittura è prigione da cui non si evade, e che anzi costituisce sì un limite all’espansione dello spirito poetico, ma come un’entità che nel contempo preserva ed incarcera.
La scrittura di Landolfi, al centro del nuovo libro di Paolo Zublena (La lingua-pelle di Tommaso Landolfi, Firenze, Le Lettere, 2013), è infatti pelle, una superficie che nutre la sostanza isolandola, e infine fa tutt’uno con essa. Nei saggi raccolti all’interno del suo volume Zublena, presupponendo la perfetta coesistenza della lingua-pelle e dei suoi bui recessi di senso, si dispone a indagare quella per venire a capo di questi, tracciando così il profilo di una scrittura letteralmente viva, pulsante, inscindibile nelle sue parti.
In occasione dell’uscita del libro, su gentile concessione dell’autore, il sito del Centro Studi Tommaso Landolfi propone un estratto dalla sua Introduzione.
La lingua-pelle di Tommaso Landolfi, pp. 7-11
di PAOLO ZUBLENA
Uno dei luoghi comuni con cui Tommaso Landolfi è stato – si può dire: fin da subito – marchiato è la presunta difficoltà formale dei suoi testi, che non appariva ad amici e interpreti della prima ora disgiunta dall’allure aristocratica e dall’istrionica reputazione di attore mancato che l’uomo Landolfi lasciava dietro di sé, mitologizzando consapevolmente una vita a suo modo esemplare, e come tale rappresentata dai ricordi più o meno finzionalizzati dei suoi amici e nemici(1). In effetti, la parte di verità che quel luogo comune coglieva è riferibile alla costante impressione – inevitabile di fronte alla sua opera – di travestimento, di copertura, di difesa opposta all’irruzione di qualcosa che rimane escluso dalla superficie della rappresentazione, ma che allo stesso tempo la motiva e la innerva.
Il percorso qui tentato ha come oggetto principale l’analisi e l’interpretazione della veste linguistico-stilistica che ha caratterizzato – come ingrediente certo non secondario – la vasta e varia produzione di Landolfi. Il racconto più o meno lungo delle origini, il romanzo breve, i diari, il teatro e la poesia – anche volendo riconoscere la discontinuità che data agli anni ’50, e che riguarda soprattutto le conseguenze tematiche e, in parte, formali di un’esigenza sempre più pressante di messa a nudo e insieme schermatura del sé autobiografico(2) – mostrano comunque un filo rosso nella scelta del materiale linguistico e della sua messa in forma che non si saprebbe descrivere meglio che come tendenza all’uso di maschere, e in primo luogo di una maschera aulica e manierista variamente sottoposta a complicazioni, fratture e tormenti: instancabile impresa di travestimento e copertura, appunto. La differenza fondamentale – dal punto di vista stilistico, quello che qui più ci interessa – tra il primo e il secondo Landolfi sta proprio nella qualità e nella quantità degli sfregi o degli irrigidimenti che questa maschera ha subito.
Si potrebbe infatti pensare che lo squisito guardaroba manierista si laceri per mettere a nudo un corpo autentico nella stagione dominata dai tre diari (LA BIERE DU PECHEUR [1953], Rien va [1963], Des mois [1967]): che la maschera si dissolva per lasciare spazio a un vero sé, o almeno alla finzione di un vero sé. A ben vedere, niente di tutto ciò: «Neppure il gesto di gettare la maschera, in realtà, è davvero risolutivo. […] Caduta la maschera non appare il volto, ma un’altra maschera. A fabbricarla è il linguaggio, l’artificio (della recitazione interrotta) in luogo dell’atto, e sempre entro le coordinate modali di un confessare (un dire di dire, un dire al quadrato) ove l’autentico si manifesta unicamente quale funzione subordinata all’autonomo articolarsi della costruzione finzionale»(3). Tolta una maschera, si indossa un’altra maschera, magari più sofferta, più vicina ai tratti dell’autore empirico: ma sempre una maschera, e vistosamente tale.
Questo libro ha un centro, ed è senz’altro il secondo capitolo. Nato come analisi stilistica di Rien va, si è poi precisato come tentativo di descrivere e interpretare la scelta linguistica di Landolfi, e non solo del Landolfi diaristico, nei termini di quella che ho scelto di chiamare lingua-pelle: cioè il succedaneo linguistico di un involucro psichico che ha faticato a svilupparsi, a partire dal costrutto concettuale (l’io-pelle) individuato e investigato da Didier Anzieu(4). La scorza linguistica che nel saggio che qui occupa lo spazio del primo capitolo era stata interpretata come formazione reattiva (rispetto a un desiderio inconscio rimosso) in termini freudiani classici, viene ricondotta a una configurazione narcisistica, ovviamente non incompatibile con la dominante malinconica che ovunque possiamo cogliere in Landolfi a livello tematico, e che – nell’ambito di questo libro – è indagata soprattutto nel capitolo sulla tarda produzione poetica (il quarto). È ben noto, anzi, che Freud, fin dall’Introduzione al narcisismo, ha considerato la melanconia come la nevrosi narcisistica per eccellenza (e il concetto mantiene forse una sua forza individuante, per quanto la psicoanalisi attuale tenda a non servirsi più di questa categoria). Il ritiro della libido sull’Io, e quindi la costruzione del soggetto e delle sue manifestazioni su una base difensiva, caratterizza senza dubbio tutto il primo Landolfi, quello più propriamente narratore: la struttura difensiva è costituita da una pelle linguistica corazzata (lessico aulico ottocentesco, toscanismi, alto tasso di intertestualità, sintassi complessa – soprattutto al livello dell’ordine delle parole: pelle che raggiungerà il suo massimo di spessore nel parossismo manieristico del Landolfo VI di Benevento – alla cui analisi è qui dedicato il terzo capitolo), mentre il desiderio inconscio fa la sua comparsa in formazioni di compromesso, come possono essere il canto di Gurù o l’oltranza fantastica di tanti racconti, ma sempre sotto la sorveglianza di una cura formale diuturna e inderogabile. Il secondo Landolfi – quello dei diari – conosce invece la pena degli auto-attacchi masochistici, se così si possono interpretare le sconciature tipografiche, le varie incisioni sul corpo-lingua, le autodenigrazioni metalinguistiche e metatestuali. Il miraggio salvifico diventa qui – e tale resterà nella terminale produzione poetica – quello della reintegrazione assoluta e insieme annichilente. In altre parole, l’aspirazione al narcisismo primario(5) – il ritorno nullificante nell’alveo del ventre materno(6): quello così spesso, disperatamente, invocato ancora in Viola di morte, e poi aspramente rimpianto – come possibilità ormai anch’essa svanita – nel Tradimento.
NOTE:
(1) Per fare un solo – memorabile – esempio, andrà qui ricordato il racconto Lo scrittore del prima amico, poi nemico Antonio Delfini, che contiene un idiosincratico ma fulminante ritratto di quello che era appunto, per eccellenza, uno scrittore già leggendario. Il racconto (del 1944-45) fa parte della Rosina perduta (Vallecchi, Firenze 1957) e si può leggere ora in Scuole segrete. Il Novecento italiano e Tommaso Landolfi, a cura di Andrea Cortellessa, Aragno, Milano 2009, pp. 29-34.
(2) Da rimarcare la segnalazione di questa discontinuità a partire da Cancroregina (1950) in Edoardo Sanguineti, Tommaso Landolfi, in Letteratura italiana. I contemporanei, II, Marzorati, Milano 1963, pp. 1527-1539. Giustamente Andrea Cortellessa ha messo in guardia nei confronti di una visione continuista della parabola di scrittura landolfiana: «Con questa impostazione, si finisce per perdere completamente di vista quel crinale “mitico”, quello spartiacque decisivo, che nell’opera di Landolfi permette di considerare due mondi espressivi e simbolici, due strategie scrittorie, in definitiva due dimensioni autoriali (pur restando avvisati della continuità genetica che tra queste due dimensioni naturalmente intercorre); si cancella insomma quella crisi che pure attente recensioni contemporanee non faticarono a diagnosticare, nella scrittura di Landolfi: quella crisi del mondo fantastico e “surreale” giovanile che portò lo scrittore ad abbandonare (tranne poche e straordinarie eccezioni) la stessa forma del racconto lungo, che aveva portato a una definizione perfetta nel periodo immediatamente precedente alla guerra, per concentrarsi, da una parte su forme di scrittura “altra”, e dall’altra sul racconto breve-elzeviro» (Caetera desiderantur: l’autobiografismo fluido dei diari landolfiani, in Le lunazioni del cuore. Saggi su Tommaso Landolfi, a cura di Idolina Landolfi, La Nuova Italia, Firenze 1996, pp. 77-106, alla p. 78). Pur nella differenza dei temi, delle forme testuali, delle modalità di enunciazione, va però riscontrata una continuità nell’azione manierista di esibizione di una maschera, che – in modi diversi – fa sempre argine all’emergenza delle pulsioni provenienti dallo strato più profondo dell’apparato psichico.
(3) Filippo Secchieri, L’artificio naturale. Landolfi e i teatri della scrittura, Bulzoni, Roma 2006, p. 45.
(4) Didier Anzieu, Le moi-peau, Bordas, Paris 1985, trad. it. L’io-pelle, Borla, Roma 2005.
(5) Si potrebbe esitare nell’uso di questa categoria, visto che, almeno in Freud, designa uno stadio precoce di onnipotenza o autosufficienza riferibile a un’età in cui la libido non investe ancora sugli oggetti esterni o addirittura alla vita intrauterina. Forse è più appropriato evocare il concetto di «narcisismo negativo», individuato da André Green: «tanto la coerenza teorica quanto l’esperienza clinica ci consentono di postulare l’esistenza di un narcisismo negativo, oscuro doppio dell’Eros unitario del narcisismo positivo, giacché ogni investimento d’oggetto, come anche dell’Io, implica un proprio doppio rovesciato che mira a un ritorno regressivo al punto zero. […] il narcisismo negativo mira all’inesistenza, all’anestesia, al vuoto, al bianco (dall’inglese blank che si traduce con la categoria del neutro), sia che questo bianco investa l’affetto (l’indifferenza), la rappresentazione (l’allucinazione negativa), il pensiero (psicosi bianca)» (André Green, Narcissisme de vie. Narcissisme de mort, Editions de Minuit, Paris 1983, trad. it. Narcisismo di vita. Narcisismo di morte, Borla, Roma 2005 [terza edizione], pp. 47-48).
(6) L’immagine della madre morta – spesso vagliata tematicamente nel capitolo quarto, quello dedicato al tema della morte nei libri di poesia – è oggetto di un tentativo di analisi, diciamo alla grossa, lacaniana nell’ultimo breve capitolo del libro, quasi un’appendice, che si sofferma sulla descriptio di una terribile – sovranamente inquietante – fotografia contenuta in Des mois.